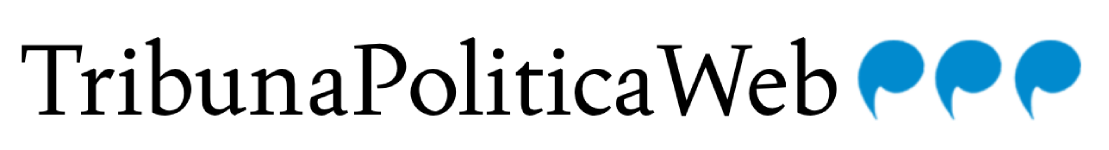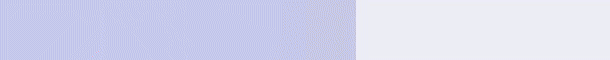Commissione Consigliare per le riforme istituzionali: audito il professor Giuseppe de Vergottini
Commissione Consiliare Speciale per le riforme istituzionali
Martedì 21 ottobre 2025, pomeriggio
Nel pomeriggio sono proseguite le audizioni nella Commissione Consiliare per le riforme istituzionali. Protagonista Giuseppe de Vergottini, Vice Presidente e Membro effettivo del Collegio Garante della Costituzionalità delle Norme. che ha offerto un ampio contributo di riflessione sulle prospettive di aggiornamento dell’ordinamento sammarinese.
Fin dall’apertura del suo intervento, De Vergottini ha espresso “piena sintonia con l’impostazione del professor Giostra”, intervenuto nella sessione mattutina, e ha posto l’accento sulla necessità che ogni riforma “non contraddica i cardini della tradizione costituzionale sammarinese”. Modernizzare l’ordinamento, ha spiegato, è legittimo e auspicabile, ma “il desiderio di allinearsi agli ordinamenti più aggiornati non deve tradursi in una sfiducia verso le istituzioni tradizionali”. Il professore ha richiamato il valore delle consuetudini costituzionali e del patrimonio giuridico e culturale della Repubblica: “Ciò che può sembrare vecchio o superato, in realtà è la vostra forza: va salvaguardato e valorizzato”.
Ampia parte della relazione è stata dedicata al Collegio Garante della Costituzionalità delle Norme, che secondo De Vergottini “necessita di qualche messa a fuoco e aggiornamento”. Il docente ha evidenziato la contraddizione tra effettivi e supplenti, auspicando un maggior riconoscimento per questi ultimi: “Molti supplenti meriterebbero di essere effettivi; la loro precarietà non giova alla serenità del lavoro professionale”. Ha inoltre proposto di rafforzare la struttura di supporto al Collegio con personale dedicato, “una collaborazione fissa e qualificata che assicuri assistenza giuridica e tecnica”.
Tra le criticità più rilevanti, De Vergottini ha ricordato la “situazione abnorme” per cui lo stesso Collegio si trova a giudicare sia come organo di garanzia costituzionale sia come giudice d’appello nei procedimenti disciplinari della magistratura: “Si crea un corto circuito istituzionale improprio: occorre assegnare la competenza disciplinare a un organo distinto”. Il professore ha espresso apertura all’introduzione di un Ombudsman o difensore civico, “un mediatore con poteri di indagine e raccomandazione che garantisca la buona amministrazione”. Tale figura, ha sottolineato, “potrebbe alleggerire la giurisdizione e dare ai cittadini risposte rapide e non onerose”, mantenendo però chiara la distinzione con l’attività giudiziaria.
Sul fronte delle fonti normative, De Vergottini ha suggerito di riflettere sul sistema dei decreti legge, distinguendo i casi in cui sia necessaria la conversione in legge da quelli in cui il provvedimento d’urgenza può esaurire i propri effetti: “Non sempre è corretto pensare che ogni decreto debba essere convertito; a volte basta riconoscere la responsabilità politica dell’esecutivo”.
Nel dibattito successivo, Gian Carlo Venturini (Pdcs) ha condiviso la necessità di “mantenere un sistema garantista” ma ha invitato a valutare con cautela la creazione di nuovi organi in una realtà piccola come San Marino. Nicola Renzi (Rf) ha sottolineato che “l’ampliamento delle competenze del Collegio Garante rischia di indebolirne la credibilità”, mentre Fabio Righi (D-ML) ha proposto di affrontare le riforme “per cerchi concentrici, mantenendo una visione complessiva dei pesi e contrappesi istituzionali”.
In chiusura, De Vergottini ha richiamato la Commissione per le Riforme istituzionali alla prudenza e alla selettività: “Non si può riformare tutto insieme. Bisogna scegliere le priorità, muovendosi con delicatezza per non compromettere ciò che funziona”.
Di seguito una sintesi dei lavori
Comma 2 – Audizioni
Professor Giuseppe De Vergottini: Vorrei iniziare ringraziando per l’invito. Stamattina abbiamo avuto già una relazione e un dibattito con la presidenza del nostro presidente del collegio, professor Glauco Giostra. Io vi dico subito che di massima mi ritrovo nell’intervento del professor Giostra, per cui condivido con lui l’impostazione che ha dato la sua relazione. Io farei una brevissima premessa come cappello. Prendo atto di quelli che sono i propositi della vostra legge qualificata che ha previsto il ruolo di questa Commissione in funzione di eventuali future modifiche dell’assetto costituzionale complessivo dell’ordinamento sammarinese. Quello che mi premeva sottolineare è che qualsiasi riforma si possa fare in prospettiva non può non essere in linea con quelli che sono i cardini della tradizione costituzionale sammarinese. Cioè, il desiderio – probabilmente in parte giustificato – di compiere degli interventi sull’ordinamento, non deve assolutamente, secondo me, dare l’impressione che ci sia una sorta di sfiducia in quelle che sono le vostre istituzioni tradizionali. Quindi il patrimonio culturale, non solo giuridico di San Marino, è assolutamente eccezionale. Io ricordo i lavori anche della famosa commissione Astuti. Il desiderio di equipararsi o di livellarsi agli ordinamenti contemporanei più aggiornati, perfettamente comprensibile, giustificabile, apprezzabile, non deve portare all’idea di contraddire quelli che sono i cardini delle vostre istituzioni. Faccio un esempio: pensiamo al ruolo delle consuetudini anche costituzionali. È chiaro che tutto questo è un patrimonio culturale che non può essere messo in discussione, deve essere semmai valorizzato. Quindi tutti gli interventi che si fanno, nel principio devono essere compatibili col fulcro di questa traduzione. Quindi, d’accordo per quanto riguarda l’articolazione dei poteri costituzionali. D’accordo per quanto riguarda il mantenimento dei principi dello stato di diritto. D’accordo su tutto, però sempre mantenendo quello che, se volete, può sembrare a volte un po’ vecchiotto, superato, ma in realtà non lo è. Quindi questi valori vanno salvaguardati. Seguendo quello che ha detto stamattina il professor Giostra, partirei da quello che è il ruolo del collegio Garante previsto dall’attuale legislazione. Qui effettivamente si sente il bisogno, come è stato spiegato mi pare molto bene, di qualche messa a fuoco, qualche aggiornamento. Noi abbiamo, come è stato detto e sottolineo, un’apparente contraddizione: il ruolo dei supplenti e ruolo degli effettivi. Giostra è stato chiarissimo su questo, quindi quello che vorrei dire è: non perdiamo la possibilità di valorizzare la professionalità de professionisti che hanno ruolo dei supplenti che però sono preziosi nel lavoro del Collegio. Questo mi sembra di dirlo in virtù dell’esperienza che ho avuto in questi anni. Alcuni di questi supplenti avrebbero strameritato di essere effettivi, per cui si trovano in una situazione a volte un po’ ingrata perché sono coscienti del fatto che sono chiamati a svolgere lo stesso ruolo molto vicino a quello degli effettivi, però con una situazione di precarietà che obiettivamente non giova alla serenità del lavoro professionale. C’è un problema, per esempio, di affinamento settoriale di competenze. Cioè, un Collegio formato da tre effettivi è un numero francamente molto ristretto. A volte si può trovare scoperto perché, per esempio, ci possono essere problemi assolutamente specialistici ad esempio sul diritto tributario. Non parliamo del penale perché adesso sta vivendo un momento particolarmente florido perché i penalisti tra effettivi e i supplenti sono più di uno. Comunque c’è un problema di competenza effettivamente. Quindi si potrebbe partire dal fatto di domandarsi: ma tre effettivi sono sufficienti o dovrebbero essere di più, per esempio? Oppure la cosa più interessante è stata quella di vedere se i supplenti potessero essere come dei preordinati a uno futuro consolidamento di ruolo, per cui dopo una certa gavetta come supplente, diciamo, il potere politico invece di cercare altri effettivi al di fuori del numero degli esistenti, potrebbe utilizzare il supplente per consolidarlo nel suo ruolo. Sono punti interrogativi che vi sono stati sottoposti stamattina, che mi permetto di confermare. Un’altra questione importante per quanto riguarda il Collegio è quella della assistenza ai componenti del Collegio stesso. La legge prevede oggi un funzionario di cancelleria e un segretario, e prevede che ci sia la possibilità, in caso di bisogno, di sostituire il cancelliere con il funzionario della segreteria per questioni istituzionali. Quindi si è già, diciamo, individuato una via di fuga in caso di bisogni. Però qui sarebbe auspicabile, credo, avere una collaborazione fissa dedicata esclusivamente al Collegio, collaborazione che può essere trovata in persone che abbiano una formazione giuridico professionale particolare che siano quindi effettivamente d’appoggio nella ricerca di documentazione, nella predisposizione degli atti preparatori, nel perfezionamento di atti. Insomma, praticamente una collaborazione molto specifica e specialistica. Questo ovviamente è un auspicio. Io tempo fa parlando di questo problema avevo detto che sarebbe auspicabile che il Collegio avesse un referendario che facesse tutta la parte preparatoria. In realtà avevo usato un termine sbagliato perché il referendario del gergo professionale giuridico italiano in realtà è un magistrato di primo livello. Quindi non è solamente un collaboratore professionale, ma magistrato. Cioè qualcuno che inizia la sua carriera in vista di consolidare il suo ruolo con definitività. Quindi la qualificazione esatta sarebbe quello di avere un assistente, cioè una persona che in Italia viene ad appoggiare il ruolo del giudice costituzionale in una fase preparatoria di assistenza strumentale. Tutto ora può servire, ma non è qualcuno che ha un’aspettativa di svolgere la funzione di giudice in prospettiva. È una cosa diversa, è un assistente, quindi è una persona che svolge il suo ruolo in pendenza del mandato del giudice costituzionale. Comunque su questo si può ragionare, chiaramente. Quindi, a parte le qualificazioni, bisogna capire se il potere politico riconosce che il Collegio abbia effettivamente necessità di essere strutturato dal punto di vista dell’assistenza in modo tale da potere avere, diciamo, a disposizione la professionalità solo esclusivamente per il Collegio. Tanto per essere chiari, quindi direi, se possibile non frammentare un eccesso di compiti in testa a un soggetto che fa parte della struttura amministrativa esistente presso le istituzioni sammarinesi. Questo può essere uno dei problemi da considerare in prospettiva. Quello che mi interessava accennare, perché ho visto che oggi il professor Giostra ha fatto una specie di elenco di quelle che sono state le proposte, i suggerimenti di eventuali modifiche ai procedimenti di fronte al Collegio per ho ricordato l’ipotesi dell’introduzione di una figura simile a quello che succede in Spagna o nei paesi liberoamericani. Ha ricordato l’ipotesi del ricorso diretto di costituzionalità da parte del cittadino che vuole andare di fronte al Collegio in modo diretto come in Germania. Poi particolare ha parlato dell’introduzione della micro scuria come è stato fatto nella Costituzione per la Corte italiana quindi ci sono tutta una serie di situazioni che possono essere prese in considerazione per quanto riguarda diciamo l’eventuale ampliamento delle competenze del Collegio. La cosa importante è stata quella è stato in riferimento alla strana situazione che si è creata nella pratica sammarinese, per cui per quanto riguarda i procedimenti disciplinari della magistratura si è previsto una competenza in serie di appello al Collegio di garanzia. Ma questo è una situazione tanto per dare un’idea. Nel momento pensate a quello che è successo nel momento in cui di fronte al collegio in un procedimento di appello disciplinare si si innesti una questione di costituzionalità, si arriva alla situazione veramente abnorme assurda per cui lo stesso organo che il Collegio garante a seconda delle situazioni si trova ad avere il cappello del giudice di appello disciplinare, oppure quello di giudice di costituzionalità. È chiaro che si crea una frammissione che è assolutamente impropria. Quindi questo è veramente un nodo che in prospettiva, a prescindere da quello che diceva oggi Giostra, a prescindere dalle strate da seguire, però in prospettiva credo che andrebbe affrontato trovando la possibilità di assegnare la competenza dell’appello disciplinare ad un organo esterno e differenziato rispetto al Collegio. H visto che nell’elenco degli argomenti che voi avete considerato come possibili c’è anche l’introduzione dell’Ombudsman. Questo è un punto di cui mi pare questa mattina non si sia parlato. Quello che in diversi paesi si chiama Commissario parlamentare, cioè il fiduciario parlamentare per la verifica della correttezza dell’azione amministrativa, cioè per la garanzia della buona amministrazione, è un’istituzione che esiste in numerosissimi paesi. Quindi adesso basta prendere le relazioni della Commissione di Venezia del Consiglio d’Europa per vedere quanto sia esteso il numero di ordinamenti che ha accettato questo organo che, secondo dei casi è chiamato con nomi diversi. Indubbiamente mi pare che sia una proposta, un suggerimento, da prendere in considerazione in una logica di bilanciamento con l’attività della giurisdizione. Cioè in un momento in cui da una parte fosse opportuno sgravare il giudice, civile o amministrativo, di attribuzione di competenze per potersi concentrare sui contenziosi più rilevanti. D’altra parte trovare il modo di venire incontro alle esigenze del cittadino che desidera, vuole, si aspetta la buona amministrazione. Questo vale soprattutto nei servizi pubblici, vale nella sanità, vale nell’edilizia. Quindi tutti quelli che sono situazioni tali da non meritare l’attribuzione al cittadino di una vera e propria posizione di diritto soggettivo, ma di però riconoscere l’appropriatezza delle aspettative del cittadino, avere la buona appunto amministrazione. Fermo restando che bisognerebbe tenere ben distinti i confini tra attività dell’Ombudsman e attività del giudice perché non è un giudice pur occupandosi di cose che rasentano l’esercizio della giurisdizione. Ecco, in tutti questi casi il mediatore effettivamente potrebbe essere una soluzione intelligente, utile. Quindi dal punto di vista pragmatico, questa è una questione direi che va risolta soprattutto da parte vostra nella consapevolezza di quelli che sono i rapporti tra la giurisdizione e quello che potrebbe essere il ruolo di questo nuovo istituto da inserire nella cornice costituzionale. Quindi uno deve fare una specie di bilancio, soppesare i pro e contro e a un certo punto dire “sì, sono favorevole al mediatore perché voglio che il cittadino senza oneri particolari, senza spendere troppo, senza aspettare anni per la soluzione un suo problema, possa avere un interlocutore che prende in esame le sue lagnanze e valuta le sue aspettative e in questo caso intervenga”. E qui, come voi sapete, la cosa interessante è che l’ombudsman, nelle centinaia di paesi in cui c’è, ha dei poteri di indagine, dei poteri di raccomandazione per le soluzioni da rivolgere all’amministrazione e quindi è un organo che ha un potere, come si dice, di persuasione. Quindi non è che può ordinare, che può prescrivere, che può multare, che può – di solito – una posizione di tipo autoritativo per cui si impone. Cerca di portare a casa il risultato soprattutto attraverso verifiche. Per esempio la regione Emilia-Romagna nella parte sanità e nella parte servizi pubblici, questo sistema sembra che funzioni. Cioè il mediatore praticamente promuove sulla fase di segnalazioni, promuove un accertamento presso l’amministrazione, chiede le carte, verifica, suggerisce la soluzione e, da quello che ci dicono le statistiche, di solito riesce a portare a casa il risultato. Per esempio, molti casi di accesso agli atti che richiederebbero altrimenti ricorsi al Tar e cose di questo genere, vengono risolti attraverso un’istanza che il mediatore che il difensore civico – come si chiama da noi – porta avanti per portare a casa il risultato. Siccome quello che interessa in questo caso al cittadino è avere una risposta nella sua aspettativa, se questa risposta la ottiene in un modo molto flessibile, molto snello, molto informale, senza aver bisogno di formalità particolari, è chiaro che questa strada può potrebbe essere preferita. Quindi il ruolo dell’ombudsman merita attenzione e può essere qualcosa di utile da conseguire.
Da un punto di vista pratico, cose da dire ce ne sono tante. Per esempio a proposito delle fonti ho sentito che avete parlare del decreto legge stamattina. Una cosa che mi sembra interessante è pensare se, per le misure di urgenza, sia sempre appropriato pensare a una sorta di doppia fase per cui quando c’è la necessità di urgenza si adotta un decreto legge e poi in un secondo momento si deve convertire il decreto legge da misura temporanea in una misura definitiva con un atto legislativo. Qui la questione rischia di sembrare veramente teorica, ma in realtà non credo che lo sia sempre. Ci sono situazioni in cui non è corretto pensare che si debba risolvere la questione solamente con la conversione in legge, perché certe misure di ranco legislativo adottate dall’Esecutivo in realtà una volta ottenuto il risultato non hanno senso di essere trasformate in legge definitiva, non c’è nessun bisogno. Quindi al posto della conversione in legge, quindi del ricorso a un atto formale, la strada da utilizzare è quella di una proposta di legge finalizzata a scaricare la responsabilità dell’esecutivo. Quindi la cosa si chiude non con la legge che dà definitività a un provvedimento legislativo, ma si chiude con la esenzione della responsabilità, con il fatto di dire “io parlamento ti dico che hai fatto bene o hai fatto male ad adottare quella proposta oppure ti dico semplicemente che hai fatto bene a farla ma non c’è più bisogno per cui dal punto di vista della responsabilità la questione è chiusa e tu governo te ne vai per conto tuo senza aspettare un atto formale di conversione perché la materia non esiste più. Io avrei finito questa questa breve carrellata, anche perché ho l’impressione che le cose più interessanti ve le abbia già anticipate stamattina il professor Giostra.
Gian Carlo Venturini (Pdcs): Ringrazio il presidente e il professor De Vergottini per il suo riferimento e per le considerazioni. Concordo quando dice che eventuali interventi di modifica, di miglioramento debbano tener conto della nostra realtà e delle nostre tradizioni. A volte, infatti, provvedimenti giusti, validi e interessanti potrebbero avere difficoltà sull’applicazione perché siamo un piccolo paese, un piccolo stato, un piccolo una piccola realtà che deve garantire la sua statualità e la certezza del diritto, pur facendo i conti con la nostra dimensione. Mi ricollego a questo rispetto al discorso del Collegio garante: capisco le difficoltà che ha il Collegio nell’attuale sua composizione anche nel deliberare sulle sanzioni disciplinari. Non so se nella nostra realtà sia opportuno istituire un altro organismo che possa decidere sulle sanzioni disciplinari, sebbene si debba trovare il modo di migliorare e togliere certe problematiche che possono generare difficoltà. L’obiettivo che abbiamo in mente è quello di avere un sistema, diciamo, sostanzialmente garantista.
Prof. De Vergottini: Il problema di fondo che ho sollevato in precedenza in questa vicenda del disciplinare d’appello è che il Collegio garante è stato concepito come organo di garanzia della costituzionalità. Come ci regoliamo nel momento in cui questo organo sia chiamato ad autorizzare competenze che in realtà non hanno in modo diretto questo tipo di riferimento? Se il Collegio debba da una parte dire se una certa disposizione di legge sia compatibile con la Costituzione e dall’altra parte debba giudicare una sua responsabilità, alla fine va in corto circuito, poiché dal punto di vista tecnico utilizza una funzione completamente diversa. C’è una certa difficoltà a conciliare le due attribuzioni, e il caso che noi abbiamo vissuto nella nostra esperienza ci ha messo in una situazione veramente molto delicata. Non credo che basti cambiare solamente la composizione della formazione del Collegio, perché il Collegio, a prescindere da chi ne faccia parte, va sempre visto come un’entità unitaria. Sono un po’ perplesso, dico la verità su questo.
Nicola Renzi – Presidente (Rf): Vorrei solo aggiungere una riflessione per testimoniare come la questione disciplinare affidata al Consiglio Giudiziario sia ancora una tematica non del tutto risolta. È vero che esiste una legge approvata con la maggioranza dei due terzi, ma già al momento della sua adozione la mia forza politica aveva sollevato dubbi di opportunità, e oggi torno a rifletterci anche alla luce di quanto ci è stato riferito dal professor Giostra e dal professor De Vergottini. Il problema non è solo teorico: come ha detto stamattina il professor Giostra, è storia, è qualcosa che avete dovuto affrontare concretamente. Mi riferisco, per esempio, alla difficoltà nel comporre un collegio, in attesa della nomina di un nuovo membro, e alla conseguente sollecitazione rivolta al Consiglio Grande e Generale affinché procedesse rapidamente. Questo genera imbarazzi, perché si arriva a votare una persona sapendo già che sarà chiamata a giudicare un caso specifico. Non dico che sia necessariamente un male, ma credo che, se serve investire qualche risorsa in più per evitare situazioni di questo tipo, sarebbe opportuno farlo. Come ha ricordato il professor Giostra, San Marino non può permettersi di avere tutte le specializzazioni interne, ma deve saper trovare soluzioni creative e adeguate alle proprie dimensioni. Evitare questi colli di bottiglia non è solo questione di efficienza, ma anche di credibilità delle istituzioni. Altrimenti si rischia di compromettere la continuità e il ruolo preminente del Collegio Garante, che deve restare un organo di alto livello, dedicato al controllo di legittimità costituzionale e all’ammissibilità dei referendum, non appesantito da funzioni più prosaiche e procedurali. Capisco che in certi casi non ci siano alternative, come per i giudici superiori che non hanno altri organi cui rispondere, ma ampliare troppo le competenze del Collegio rischia di indebolire la fiducia che i cittadini e le istituzioni devono avere in esso. Inoltre, in una realtà piccola come la nostra, se i procedimenti disciplinari dovessero aumentare, rischieremmo di ingolfare i lavori del Collegio. Non ho soluzioni pronte, perché il problema è complesso e anche oneroso, ma credo che non possiamo ignorarlo e dobbiamo continuare a rifletterci.
Prof. De Vergottini: Mi scuso, mi era sfuggito di precisare un punto. Quando si parla della condizione del piccolo Stato, bisogna distinguere. Se il riferimento è alla capacità organizzativa e di risorse, allora sì, è legittimo ragionare in termini di proporzione e di buon senso, prevedendo solo ciò che è strettamente indispensabile per il funzionamento delle istituzioni. Tuttavia, quando si tratta della qualità della legislazione, il discorso cambia. Anche un piccolo Stato deve saper produrre buone leggi, ben strutturate e tecnicamente accurate. Non possiamo giustificare eventuali carenze legislative semplicemente invocando le nostre dimensioni ridotte. Il richiamo al ‘piccolo Stato’ può valere in certi ambiti pratici, ma non può diventare una giustificazione universale. Va usato con misura, con discernimento, in modo limitato e solo quando davvero pertinente.
Gian Carlo Venturini (Pdcs): Vorrei solo precisare che quando facevo riferimento al piccolo Stato non intendevo dire che possiamo permetterci di non rispettare le regole o di non garantire i diritti di tutti. Il mio era un invito a valutare con attenzione la proliferazione di nuovi organismi, che in altre realtà più grandi possono avere senso, ma che per noi rischiano di essere ridondanti. Dobbiamo razionalizzare le risorse e utilizzare al meglio ciò che abbiamo. Nel caso specifico delle sanzioni disciplinari capisco che ci siano difficoltà, ma credo che quando affronteremo il tema del Collegio Garante dovremo considerare anche la possibilità di istituire al suo interno una sezione specifica per i disciplinari. In questo modo potremmo evitare difficoltà e imbarazzi. Oggi però dobbiamo lavorare con ciò che abbiamo e, in prospettiva, migliorare il sistema per garantire la certezza del diritto e le stesse garanzie a tutti, anche se siamo un piccolo Stato.
Prof. De Vergottini: Aggiungo solo una cosa. Ho visto l’elenco degli argomenti che avete messo all’ordine del giorno e credo che sia necessario muoversi con molta delicatezza, evitando di voler riformare tutto contemporaneamente. Occorre fare delle scelte politiche chiare e privilegiare alcuni interventi rispetto ad altri, perché è irrealistico pensare di rivedere l’intero ordinamento. Concentratevi sulle priorità più urgenti, così sarà più facile ottenere risultati concreti. Inoltre, come ho già detto, il fatto di essere un piccolo Stato non può diventare una scusante generale. Ogni piccolo Stato ha caratteristiche proprie e particolarità da preservare. Non bisogna stravolgere ciò che fa parte della nostra identità istituzionale, ma piuttosto migliorarlo e rafforzarlo. Per esempio, ho visto che si parla anche di intervenire sulla Reggenza: è un tema molto delicato. Va bene se si tratta di precisare per legge gli obblighi e i doveri dei Capitani Reggenti come pubblici ufficiali, ma attenzione a non alterare gli equilibri tra le funzioni costituzionali. Sono rapporti sedimentati nei secoli, da trattare con estrema cautela. In sintesi, bisogna scegliere bene dove intervenire, evitando di voler rivoluzionare tutto e rischiare di compromettere ciò che funziona.
Nicola Renzi – Presidente (Rf): Ringrazio il professore per le sue considerazioni, che condivido pienamente. Faremo tesoro delle sue raccomandazioni. In effetti, come ricordava anche il commissario Venturini, il documento che abbiamo approvato stabilisce già un ordine di priorità preciso, che parte dal Consiglio Grande e Generale. Credo che il nostro lavoro debba concentrarsi innanzitutto su quello, consapevoli però che i risultati non potranno essere immediati. Ci sarà bisogno di tempo, di riflessione e di confronto continuo, non solo all’interno della commissione ma anche con la popolazione. Il nostro compito non è presentare soluzioni già pronte, ma costruire un percorso di riforma condiviso e ben ponderato.
Fabio Righi (D-ML): Ringrazio il professore per il suo intervento, che mi ha offerto uno spunto di riflessione in merito all’organizzazione dei nostri lavori in commissione. Noi abbiamo cercato di definire un percorso e di stabilire delle priorità di intervento, ma credo che, considerando la natura delle riforme istituzionali e dei poteri dello Stato, sia necessario tenere conto del principio dei pesi e contrappesi. Affrontare i temi solo in linea retta, seguendo un elenco rigido di priorità, potrebbe non essere del tutto coerente con i tempi e le esigenze di adeguamento delle varie istituzioni. Penso che, senza abbandonare il percorso che ci siamo dati, dovremmo affiancare anche un ragionamento più ampio, che potrei definire a cerchi concentrici. Quando si interviene su un’istituzione, come ad esempio il Consiglio, modificandone funzioni o competenze, è inevitabile che questo incida anche su altri organismi. Per questo è opportuno prevedere approfondimenti paralleli, così da garantire che l’equilibrio generale del sistema resti coerente. Procedere in questo modo ci permetterebbe di contemperare le priorità che abbiamo stabilito con interventi mirati anche su altri fronti, affrontando le questioni in modo progressivo: partendo da un cerchio più largo e poi andando via via più in profondità. È chiaro che, quando si andrà a toccare in maniera più sostanziale alcune istituzioni o uffici, servirà più tempo, maggiore approfondimento e la possibilità che le proposte si sedimentino. Tuttavia, muoversi solo in linea retta rischia di rendere il lavoro molto lungo e di trascurare altre esigenze che inevitabilmente emergono, perché ogni modifica in un punto del sistema produce effetti altrove. L’idea di lavorare per cerchi concentrici, mantenendo una visione complessiva e bilanciata, può aiutarci a svolgere un lavoro più completo e coerente con la logica della divisione dei poteri.
I lavori si interrompono verso le 16:00.