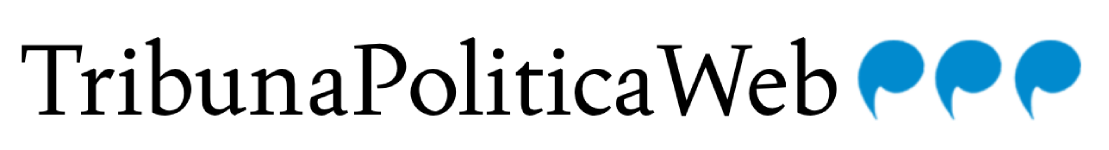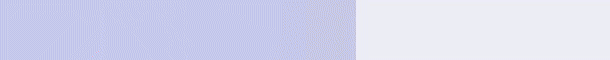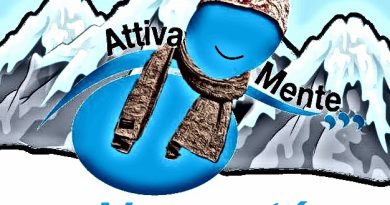Commissione Consiliare Speciale per le riforme istituzionali: prosegue il confronto
La sessione mattutina è incentrata sulla audizione di Piero De Luca, avvocato, docente universitario e Deputata della Repubblica italiana. che ha offerto una “cassetta degli attrezzi” comparata su strumenti normativi italiani e diritto dell’Unione, con molte indicazioni operative per San Marino in vista dell’Accordo di associazione UE.
Il relatore ha spiegato la differenza tra fonti europee primarie (Trattati e Carta dei diritti fondamentali) e derivate (regolamenti, direttive, decisioni). “I regolamenti si applicano direttamente; le direttive vincolano il risultato e, se chiare e incondizionate, ammettono un effetto diretto verticale in caso di mancato recepimento”, ha spiegato. “In caso di conflitto, il giudice disapplica la norma interna incompatibile con quella europea”. Da qui l’esigenza di formazione e di una rete stabile tra magistratura, avvocatura sammarinese e Corte di giustizia europea.
Per De Luca, l’ingresso nell’acquis impone di rafforzare il ruolo del Consiglio Grande e Generale: controllo di sussidiarietà, sessioni rapide entro 8 settimane, e nella fase discendente l’adozione di una “Legge di delegazione europea” periodica, una o due volte l’annp, per recepire direttive e norme di attuazione; accanto, una “Legge europea” per chiudere procedure di pre-infrazione. “Serve subito un presidio per lo screening degli allegati dell’Accordo e un portale pubblico sulla normativa UE. È un lavoro pluriennale: meglio partire ora”, il messaggio.
Il presidente Nicola Renzi (Rf) ha spinto sull’acceleratore: “Siamo in ritardo. Dobbiamo aggiornare il ‘semaforo’ sull’acquis e valutare il recepimento dinamico. L’accordo è l’estrinsecazione della nostra sovranità: saremo all’altezza?”. D’accordo Mirko Dolcini (D-ML): “Va attivato subito il presidio sugli allegati: l’impatto iniziale è il più critico”.
Paolo Crescentini (Psd) ha ricordato l’Odg che incarica il Segretario agli Interni di una relazione-organigramma su PA, recepimento, formazione e autorità di controllo: “Arriva in Consiglio nella prossima sessione”. Luca Lazzari (Psd) ha legato l’UE alla centralità del Consiglio e ai carichi di lavoro: “Servono competenze e un modello organizzativo adeguato”.
Gian Carlo Venturini (Pdcs) ha proposto di semplificare la ratifica dei decreti delegati con un parere preliminare in commissione. Iro Belluzzi (Libera) ha sollecitato la cooperazione strutturata con l’Italia e strumenti di trasparenza: “Un portale è essenziale perché la conoscenza è democrazia”.
“Partire subito con screening e formazione: è un’opportunità enorme, economica e di diritti”, è stato il consiglio finale di De Luca.
La Commissione ha anche dato mandato ai presidenti sulla relazione con la Commissione di Venezia, per l’incontro preparatorio del 12 novembre e l’audizione 2 dicembre.
Di seguito una sintesi dei lavori
Comma 2 – Audizioni
Piero De Luca – relatore: Ringrazio presidenza per l’invito. Ringrazio ovviamente la Commissione consiliare speciale per le riforme istituzionali per aver deciso di di di invitarmi a esporre una relazione poter dare un contributo ai lavori e al che sono poi oggetto centrale del mandato della della commissione stessa legata al rafforzamento del potenziamento del ruolo indirizzo politico legislativo del consiglio Grande Generale, a uno studio sulla gerarchia delle fonti normative e tra l’altro alla possibilità di focalizzare e approfondire il rapporto tra ordinamento dell’Unione Europea, diritto e diritto interno. Io avevo ipotizzato di dividere in due parti la relazione per calibrare e dare elementi di diritto comparato legati al diritto italiano e per quanto riguarda le specificità dei ricorsi ai decreti, che è uno degli aspetti principali del vostro mandato, dando di testimonianza del funzionamento degli istituti di decreti legge e decreti legislativi in Italia per poter dare qualche elemento indirizzo spunto di riflessione potenzialmente utile ai vostri lavori. Poi una parte successiva legata al rapporto con l’ordinamento europeo, le peculiarità dell’ordinamento dell’Unione Europea cui la Repubblica San Marino si appresta a confrontarsi. Io auspico favorevole ovviamente dal mio punto di vista firma e processo di ratifica successiva dell’accordo di associazione tra l’Unione Europea e San Marino oltre che Andorra. Entro subito nel merito per essere concreto. In Italia l’articolo 70 della Costituzione attribuisce la funzione legislativa collettivamente a due Camere, come sapete bene meglio di me, Camera e Senato. La stessa Carta Costituzionale però prevede due articoli specifici, articolo 76-77, che disciplinano due ipotesi in cui anche il gover governo può adottare atti aventi forza di legge, non solo il parlamento, ma anche il governo. L’articolo 76 disciplina la il funzionamento dei cosiddetti decreti legislativi. Che cosa sono i decreti legislativi? Sono degli strumenti, degli atti legislativi che possono essere adottati dal governo previa determinazione di principi e criteri direttivi per tempo limitato e per oggetti definiti da parte del Parlamento attraverso una legge delega, una legge di delegazione. Cioè il Parlamento ha la possibilità di elaborare, di emanare, di adottare una legge delega all’interno della quale conferisce al governo il potere di adottare più uno o più decreti legislativi su una maniera specifica. Le particolarità di questo istituto sono legate all’esigenza che il Parlamento indichi esattamente nella legge delega o la legge di delegazione principi e criteri direttivi il governo deve attenersi, oggetto e ambito specifico della delega e il termine entro cui esercitarlo. Questi sono elementi che caratterizzano la peculiarità della legge di delegazione che il Parlamento può elaborare per attribuire al governo, diciamo, la possibilità di adottare dei decreti legislativi. La legge attribuisce con la specificazione di questi elementi una delega che però il governo deve esercitare all’interno del perimetro indicato da questi criteri e con la possibilità di prevedere anche forme di controllo parlamentare sull’attività delegata, come la trasmissione degli schemi di decreto legislativo che il governo intende adottare alle commissioni competenti per un parere di merito. Il Parlamento, in sostanza, una volta adottata la legge di delegazione europea, non torna più nella approvazione della norma, però ha una possibilità di alimentare il dibattito col governo attraverso le commissioni parlamentari competenti che possono analizzare gli schemi preliminari di decreto legislativo che quel governo si appresterà definitivamente adottare. Il decreto legislativo è dunque un atto del governo con forza di legge, prevede che ci sono dei limiti, come vi rappresentavo, che sono stati rafforzati e precisati anche dalla Corte costituzionale interna perché in caso di eccesso di delega, cioè nel caso in cui il governo non rispetti in modo pedisseco, esatto, corretto i principi e i criteri direttivi, il decreto legislativo del governo può essere oggetto di un controllo dinanzi alla Corte Costituzionale di costituzionalità stesso, perché i principi e criteri direttivi sono richiesti alla nostra Costituzione. Per cui in caso di eccesso di delega quel decreto legislativo può essere sottoposto a un vaglio di costituzionalità ed essere dichiarato nella parte eccedente i criteri e principi direttivi incostituzionali. I decreti legge previsti dall’articolo 77 della Costituzione invece sono, diciamo, atti aventi forza di legge di carattere provvisorio adottati ai sensi della Costituzione in circostanze straordinarie di necessità e urgenza, in cui è indispensabile, ovviamente per da un punto di vista politico istituzionale, da parte del governo intervenire in modo immediato con un decreto che è appunto un decreto legge, il quale è deliberato al Consiglio dei Ministri, emanato dal presidente della Repubblica, immediatamente pubblicato in Gazzetta Ufficiale e quindi entra in vigore lo stesso giorno della pubblicazione. Questo decreto deve però essere convertito entro 60 giorni dal Parlamento. Se la legge di conversione non viene approvata in totale termine, il decreto perde efficacia sin dall’inizio e restano validi ovviamente alcuni effetti prodotti nel periodo di vigenza salvo diversa disposizione del Parlamento riguardo agli effetti agli effetti transitori. Anche da questo punto di vista c’è una legge, la legge 400 del 1988, che disciplina forma e contenuti dei decreti legge, precisati anche questi dalla Corte Costituzionale, richiedendo omogeneità di materia per evitare decreti omnibus adottati con carattere di urgenza e un limite di contenuto per evitare appunto norme intruse, come vengono definite o norme che non hanno quel requisito di necessità e urgenza e che invece potrebbero essere inserite in via surettizia in quest questo tipo di provvedimento, il fenomeno della teso a evitare l’eterogeneità di leggi. Ovviamente si estende anche alla fase di conversione parlamentare perché, anche in fase di conversione parlamentare, le Camere sono tenute a non inserire in questo veicolo normativo che va convertito in norme che sono estrane al perimetro iniziale del decreto stesso, pena il venir meno del prerequisito iniziale della necessità e dell’urgenza. Questi decreti, ovviamente, rappresentano un’ulteriore ipotesi di intervento legislativo del governo del nostro ordinamento e sono anch’essi soggetti sempre più ad un vaglio di rispetto di questi requisiti che sono indispensabili per evitare che si alteri l’equilibrio di poteri all’interno del nostro ordinamento.
Arrivo alla parte legata al diritto europeo. Il diritto nazionale, sin dagli anni ‘50 in Italia, così come dei primi sei stati membri fondatori dell’Unione Europea e attraverso le successive evoluzioni, ad oggi riguarda 27 stati membri più altri stati che sono collegati con accordi di associazione EFTA o, speriamo quanto prima dal mio punto di vista, anche l’accordo di associazione che riguarderà la Repubblica San Marino e il principato di Andorra. Dagli anni ’50, da quando sono state istituite le prime comunità europee Euraton con la CECA e la CE, con i primi trattati istitutivi del ‘52 di Parigi e ‘57 di Roma è sorto nel diritto nazionale degli Stati membri l’esigenza di coordinare l’ordinamento interno con un ordinamento di nuova specie come è stato definito dalla dottrina e dalla giurisprudenza, che è l’ordinamento dell’Unione Europea, un ordinamento che è sui generis rispetto agli ordinamenti internazionali. Ci tengo a precisare questo elemento sin dall’inizio perché entrare a far parte dello spazio giuridico europeo vuol dire entrare a far parte anche di un insieme di norme, principi, regole che sono indicate semplificativamente in una locuzione, una formuletta che è inserita anche nella vostra proposta di accordo di associazione che si chiama acquis communautaire, ossia tutto l’insieme di patrimonio giuridico istituzionale giurisdizionale che fa parte oggi dell’architettura istituzionale dell’Unione Europea. Questo vuol dire innanzitutto avere la piena consapevolezza di come interagisce il diritto europeo rispetto al diritto interno e al diritto nazionale. Il diritto europeo, diciamo, si divide in fonti di diritto privario e fonti di diritto derivato. Fonti di diritto privato sono le norme indicate attualmente dal trattato sull’Unione Europea e dal trattato sul funzionamento dell’Unione Europea. A queste si sono aggiunte altre nel tempo. Nel 2001 è stata adottata la carta diritti fondamentali di Nizza con una serie di prescrizioni legate ad alcuni diritti fondamentali anche di natura costituzionale che rappresentano l’elemento identitario dell’Unione Europea stessa con principi alcuni dei quali erano anche già nell’articolo attualmente due del trattato sull’Unione Europea di Lisbona, Carta dei diritti fondamentali che era un accordo interistituzionale creato con accordo nel 2001 tra le varie istituzioni europee che aveva un’efficacia giuridica anche lì particolare perché è entrato a far parte dell’ordinamento dell’Unione attraverso cosiddetti principi generali del diritto attraverso la giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea. Dopo l’ approvazione del trattato di Lisbona è entrato in vigore del 2009, l’articolo 6 comma3 del trattato sull’Unione Europea ha recepito formalmente come fonte diritto primario nell’ordinamento europeo anche la carta dei diritti fondamentali, per cui le norme previste in questa carta hanno la stessa efficacia valore giuridico delle norme dei trattati.
Accanto a queste norme di diritto primario si aggiungono norme di diritto derivato che sono previste e disciplinate dalle cosiddetti fonti che conoscete bene anche voi, normative ordinarie, diciamo così, legislative dell’Unione. Innanzitutto i regolamenti, direttive e decisioni. A queste si affiancano due tipi di fonti che non producono effetti giuridici vincolanti come i pareri e le raccomandazioni. L’articolo 288 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea indica un po’ le caratteristiche principali di queste fonti. Il regolamento ha portata generale, io ci terrei ora a leggere semplicemente, diciamo, le caratteristiche dei trattati, ma poi a esplicitarle con un minimo di dettaglio perché avranno un impatto e un rilievo nei termini che vi proverò a rappresentare anche nell’ordinamento sammarinese al momento della entrata in vigore dell’accordo di associazione.
I regolamenti europei hanno portata generale, sono obbligatori in tutti i loro elementi e direttamente applicabili in sedimento. Le direttive invece vincolano gli stati membri cui sono rivolti per quanto riguarda il risultato da raggiungere, fermo restando la competenza nazionale in merito alla forma e ai mezzi per raggiungere gli obiettivi indicati nelle direttive. Le decisioni sono obbligatorie in tutti i suoi elementi, ma sono perlopiù atti che hanno un destinatario specifico o uno più destinatari individuati in modo specifico, quindi non hanno le caratteristiche della generalità e la astrattezza propria dei provvedimenti di carattere legislativo e sono obbligatorie soltanto nei confronti dei destinatari delle decisioni. Raccomandazioni e pareri sono atti invece di carattere non vincolante che vengono adottate a seconda dei procedimenti previsti nei trattati dalle differenti istituzioni a seconda dei casi specifici. Quanto ai regolamenti, l’elemento centrale su cui porre l’attenzione, perché ve ne sono tanti anche inseriti negli allegati che accompagnano l’accordo di associazione, è questo: sono quando adottati secondo la procedura legislativa dell’Unione Europea, che possa essere ordinario speciale, non c’è tempo entrare nei dettagli, hanno carattere legislativo e producono effetti in modo diretto e immediato negli ordinamenti nazionali. Cioè non necessitano una norma di recepimento nazionale, producono i loro effetti in modo immediato dal momento della loro entrata in vigore a livello europeo, per cui le fonti, i diritti, gli obblighi, le opportunità giuridiche riconosciute all’interno di questi regolamenti producono un effetto diretto negli ordinamenti nazionali. Le direttive – e da questo punto di vista poi arriviamo sul rapporto con le norme interne eventualmente confligenti – invece hanno lo scopo di armonizzare l’ordinamento degli ordinamenti nazionali e sono destinate principalmente agli stati, i quali devono recepirle nel diritto interno. Quindi per un obbligo di recepimento delle norme – e le direttive entro un termine per la maggior parte dei casi sempre indicato nella direttiva stessa di recepimento – sono rivolte quindi principalmente agli Stati per quanto riguarda l’obiettivo. Anche queste nel corso del tempo hanno riconoscimento della giurisprudenza della Corte di Giustizia perché possono in alcuni casi produrre determinati effetti anche della trasposizione nazionale in caso di mancato ricevimento da parte di uno stato membro o di ricevimento nei confronti da parte dei privati nei confronti dello Stato, delle pubbliche amministrazioni. È il cosiddetto effetto diretto verticale delle direttive che hanno al loro interno già delle norme chiare, precise e incondizionate. Quindi quando ci sono le direttive che hanno norme già chiare, precise e incondizionate al loro interno, nel caso in cui gli Stati non recepiscano dai termini previsti la sanzione, diciamo così, l’effetto è la possibilità di poter invocare da parte dei privati, dei cittadini nei confronti di una pubblica amministrazione o dello Stato per esempio in materia di diritto di lavoro, in materia di previdenza sociale, in materia di formazione professionale, in materia di tempi di lavoro o altre hanno dei diritti che vengono conosciuti direttamente dalla direttiva. Questo stesso effetto non è previsto nei confronti di altri privati, nei confronti di un datore di lavoro privato. Invece un lavoratore non può invocare una norma di una direttiva sia pur chiara, precisa e condizionata che non sia stata recepita. In quel caso, allora, è prevista la possibilità di ottenere un risarcimento d’anni da parte dello Stato per il privato che invece non può invocare o non può far valere nel diritto nazionale quella prerogativa che gli è riconosciuta da una direttiva. Gli accordi internazionali sono accordi su generis che si collocano, diciamo, a metà strada tra diritto primario e il diritto derivato e gli accordi di associazione come quelli previsti ex articolo 217 del trattato sull’Unione Europea che riguarderanno San Marino, sono accordi conclusi da Stati terzi rispetto all’Unione Europea e l’Unione che creano comunque vincoli particolari e privilegiati con uno Stato terzo che deve partecipare al regime comunitario, nel limite nell’ambito delle materie che sono previste dall’accordo di associazione stesso. Perché l’accordo di associazione che San Marino ha definito, e di cui si appresta la firma all’Unione Europea, il Consiglio ha tante materie che sono incluse ma ha delle materie che sono però fuori dall’accordo di associazione almeno in questa in questa prima fase. C’è una sentenza importante della Corte di Giustizia la Demirel del 1987 nella causa 12/86 che ha affermato rispetto a un accordo di associazione fatto con la Turchia all’epoca qual è la natura giuridica delle norme degli accordi di associazione rispetto agli ordinamenti nazionali. La Corte in questo passaggio ha detto che queste norme degli accordi possono in se stesse produrre degli accordi, non delle regole europee recepite dagli accordi ma dell’accordo stesso possono avere un’efficacia diretta quando, al tenore letterale o l’oggetto la natura stessa, implichi rispetto a queste ad alcune norme un obbligo chiaro e preciso i cui effetti non sono subordinati all’adozione di atti ulteriori. Quindi vi è la possibilità, in termini astratti ai sensi del diritto europeo, che alcune norme dell’accordo possano produrre un effetto diretto senza ulteriori norme di ricevimento nell’ordinamento di San Marino. Quindi questo è un elemento di cui tener conto.
Qual è la caratteristica delle norme europee rispetto alle norme nazionali? Ed è un elemento importante da tenere in considerazione per le conseguenze e le ipotesi di lavoro che proverò a tracciarvi e che potrebbero essere interesse dalle proposte su cui andrete a lavorare come commissione. Ci sono due principi fondanti che caratterizzano oggi la peculiarità dell’ordinamento europeo e delle norme europee che sono stati definiti alla Corte di Giustizia. La prima nel ‘63 della sentenza Van Gend & Loos, che è il principio dell’effetto diretto. Le norme europee, diciamo, direttamente applicabili, producono effetti diretti negli ordinamenti nazionali. Quindi non c’è necessità di recepirla da norme come quelle dei regolamenti. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che un cittadino, un privato può invocare quelle norme direttamente dinanzi alle giurisdizioni nazionali. Non c’è bisogno per determinate tipologie di norme di una legge, di un atto di recepimento nazionale. Questo vuol dire che dal momento in cui l’accordo associazione entra in vigore per San Marino, San Marino si troverà a confrontarsi con un sistema giuridico multilivelli composto da un ordinamento interno e dalle norme dell’ordiamento europeo che voi, tutto il sistema giudiziale istituzionale, ma la società stessa sammarinese, sarete chiamati a tenere in considerazione perché saranno norme che produrranno effetti in alcuni casi diretti nell’ordinamento di San Marino e potranno essere invocate anche dinanzi alle giurisizioni sammarinesi direttamente dai privati, dai cittadini, dai lavoratori, dalle famiglie, dai pensionati, dalle imprese o da aziende a seconda degli ambiti di competenza. L’altra sentenza, diciamo, cardine che oggi ha definito i principi fondanti del diritto europeo che si applicheranno a San Marino in virtù di quella di cui ho parlato prima, è il principio della supremazia o del primato del diritto europeo rispetto al diritto interno. La sentenza Costa del 1964 della Corte di Giustizia, con un principio che poi è stato ripreso da tante Corte Costituzionali Nazionali, tra cui anche quella italiana ha affermato il principio in base al quale le norme europee, in caso di conflitto con le norme nazionali prevalgono sulle norme nazionali. Questo è un tema importante. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che se invocate dinanzi a un giudice, da parte di un’impresa, da parte di un privato, il giudice ed l’altro elemento sarà tenuto a fare cosa? A disapplicare il diritto interno, la norma interna confligente con la norma europea che insiste sulla stessa materia e che semmai prevede, diciamo, diritti, obblighi, opportunità che il diritto interno non prevede, o prevede in modo differente. In capo ai giudici nazionali sussiste oggi un obbligo di disapplicazione diretta e non c’è bisogno che il Parlamento, il Consiglio Grande e Generale, disapplichi, revochi o ritiri una legge o la modifichi. Innanzitutto il giudice potrà far valere quel diritto europeo direttamente in un procedimento giudiziario. Io mi sono occupato, per darvi un esempio concreto, della normativa spagnola sull’esecuzione ipotecaria che prevedeva che, in caso di mancato pagamento di una sola rata di mutuo ipotecario per l’acquisto di una casa su mutui di 30 anni, bastava il non mancato pagamento di una sola rata per poter dare a esecuzione i poteri immobiliari, cioè per poter riprendere, requisire la casa parte della banca e quindi cacciare fuori la famiglia. I casi di crisi finanziaria con quella del 2008-2011 sono stati centinaia e centinaia le famiglie che, per difficoltà economiche, hanno avuto un ritardo di qualche giorno nel pagamento della rata di mutui impugnano questa esecuzione dinanzi alla giurisdizione spagnola che ovviamente si rende conto che questa opportunità prevista alla normativa spagnola era legale ai sensi del diritto spagnolo. Si rendono conto però che c’è una normativa europea prevista dalla direttiva 9313 sulle clausole abusive o sulle clausole vessatorie che in realtà dava maggiori tutele al contraente debole, quindi alle famiglie che hanno contatto mutuo, nei confronti dei professionisti, quindi degli istituti di credito. Chiedono alla Corte di Giustizia, quindi tra giudici nazionale e la Corte di Giustizia, di interpretare la normativa europea per chiedere se quella nazionale fosse corretta, compatibile con la normativa europea oppure no. E la Corte di Giustizia – io ho lavorato in questo caso direttamente col giudice italiano che era relatore – abbiamo rilevato che una clausola come questa prevista nel diritto spagnolo, clausola contrattuale avallata alla normativa spagnola, fosse incompatibile con la direttiva europea. Quel giudice nazionale ha disapplicato la clausola e di conseguenza la normativa spagnola ha salvato la casa, per essere concreti, alle famiglie e ha disapplicato quella norma del contratto di mutuo, che era la fedele riproduzione della normativa interna perché ritenuta incompatibile con la disciplina europea. Non c’è stata necessità che il Parlamento spagnolo modificasse la norma di legge perché si applicasse la normativa europea. Ovviamente questo ha portato poi il Parlamento spagnolo successivamente a rivedere la normativa per adeguarla e metterla in conformità alla direttiva europea. Però intanto nel frattempo l’effetto di quella normativa è stato prodotto direttamente grazie al lavoro dei giudici. E qui arrivo per una prima suggestione.
Entrare a far parte dell’ordinamento di questo complesso multilivello di ordinamento europeo, in primo luogo porterà la necessità di rafforzare le prerogative, le competenze e la conoscenza del diritto europeo e del sistema giudiziario giurisdisionale di San Marino. Perché? Perché i giudici nazionali sono, come viene definito la Corte, giudici di diritto comune dell’Unione Europea. Saranno loro tenuti in prima battuta ad applicare norme di diritto europeo che produrranno un’efficacia diretta immediata negli ordinamenti nazionali. Quindi questo presuppone l’esigenza di rafforzare una sorta di rete di cooperazione anche europea delle giurisdizioni di confronto di formazione giudiziaria sulle tematiche europee che coinvolgerà ovviamente anche l’avvocatura perché ovviamente c’è l’altro lato della medaglia che è l’avvocatura sammarinese. Io prevedo – poi ovviamente sarà affidata ai singoli stati membri – un rafforzamento delle competenze europee di conoscenza, di applicazione degli istituti di diritto europeo da parte dei giudici del sistema giudiziario perché i giudici nazionali sono giudici di diritto comune e avranno la possibilità, non solo di applicare direttamente le norme interne, ma di poter poi dialogare con la Corte di Giustizia che è l’organismo giudiziario superiore dell’ordinamento europeo. Le giurisdizioni nazionali, qualora avessero dei dubbi sulla corretta interpretazione di una norma di diritto europeo che è invocata in un giudizio o sulla validità addirittura della norma di diritto derivato non primario europeo, avranno la facoltà e addirittura l’obbligo se giurisdizione di ultima istanza, di operare con la Corte di Giustizia dell’Unione Europea per chiedere alla Corte di Giustizia con il rinvio pregiudiziale. Non l’interpretazione della norma interna, perché la Corte di Giustizia non si pronuncia mai sulla validità della norma nazionale, ma chiarisce l’interpretazione della normativa europea di cui viene chiesta ovviamente la precisazione o chiarimenti. E su quella base ovviamente il giudice nazionale sarà poi tenuto a valutare la compatibilità, la coerenza, la conformità della normativa interna rispetto al diritto europeo. Quindi l’eventuale disapplicazione sarà e rimane sempre prerogativa dei giudici nazionali. La Corte di Giustizia però avrà la possibilità di dare un’interpretazione ovviamente autentica, l’interpretazione giudiziale. La Corte che produce peraltro effetti erga omnes in tutta l’Unione Europea, cioè l’intepretazione del caso spagnolo delle clausole abusive nei contratti di mutuo è un’interpretazione che vale, da quel momento, anche in Italia, in Spagna o in Francia, quindi deve essere poi recepita al giudice che ha operato il rinvio pregiudiziale e al quale viene fornita quell’interpretazione, ma produce un effetto interpretativo della norma europea che vale immediatamente in tutto l’ordinamento europeo, in tutti gli Stati. Questo cosa vuol dire? Vuol dire preparare le giurisdizioni nazionali a questo nuovo diritto che si troveranno a dover applicare, a confrontarsi, a far interagire con l’ordinamento interno, ma preparare anche il Parlamento all’evoluzione giurisprudenziale costante della Corte. Siccome le pronunce della Corte, anche in altri casi di sentenze pronunciate su richieste di altri stati membri producono delle interpretazioni di norme europee che poi hanno un’efficacia, una valore anche nell’ordinamento di San Marino a partire dal momento della loro emanazione. Voi avrete la necessità, come primo elemento informativo, di predisporre uno strumento che consenta non solo agli operatori del diritto ma anche al Parlamento di essere informati in modo costante, semmai su base semestrale, delle evoluzioni normative giurisprudenziali che la Corte adotta, perché alcune di queste potrebbero portare a richiedere un intervento legislativo anche vostro. Per evitare rischi di contenziosi ed evitare che i giudici debbano poi interpretare in modo conforme o no la normativa interna. Quindi questo è un primo elemento sul quale io mi sentivo di darvi qualche spunto di riflessione. La rete giudiziaria va adeguata e va, diciamo, messa in conformità rispetto alla interazione del diritto dell’Unione col diritto interno.
Vi è poi il ruolo dei parlamenti nazionali che sarà fortemente rafforzato, a mio modo di vedere, grazie alla firma, alla definizione del procedimento e l’accordo del processo di associazione con l’Unione Europea per alcuni elementi oggettivi e sostanziali. Il trattato di Lisbona prevede per la prima volta due protocolli specifici che riguarda il protocollo numero 1 e il protocollo numero 2 allegati al trattato che prevedono un rapporto e un dialogo e un ruolo delle prerogative specifiche dei parlamenti nazionali, degli Stati membri e degli stati aderenti. Per la prima volta hanno deciso di prevedere all’interno come protocolli ai trattati stessi, delle procedure che erano già previste con altre norme di carattere differente precedentemente che assegnano un ruolo specifico ai parlamenti nazionali nel rapporto con le istituzioni europee. Ci si è resi conto dell’esigenza di rafforzare il tasso di democrazia dell’Unione, di partecipazione, di trasparenza anche al processo legislativo e democratico dell’Unione implicasse l’esigenza di rafforzare il ruolo dei parlamenti nazionali. Qual è il ruolo dei parlamenti nazionali che ha portato a delle modifiche in Francia, in Germania e ad una normativa che in Italia è prevista la legge 234 del 2012? In Italia, per darvi un quadro che può essere trasposto in altri stati, le prerogative dei parlamenti nazionali riguardano la partecipazione nella fase ascendente dei parlamenti alla formazione delle norme europee. Quindi i parlamenti nazionali hanno un ruolo di partecipazione, come peraltro è previsto anche nell’accordo, già da subito alla fase ascendente di elaborazione normativa della disciplina europea, degli atti legislativi europei. Come si configura questa partecipazione? Si configura con la possibilità e con l’obbligo, questo è un elemento da valutare come eventuale ipotesi di riforma istituzionale nel rapporto tra l’esecutivo e il Parlamento. Oggi le istituzioni trasferiscono agli stati tutte le informazioni legate alle proposte di atti legislativi che vengono comunicate agli Stati nazionali. La Commissione informa gli Stati sulle proposte di atti legislativi, tenuto a farlo direttamente con i parlamenti. Però è utile da questo punto di vista, siccome arrivano spesso agli uffici dei ministeri, prevedere una forma di confronto, di rapporto di informazione tra esecutivo e parlamento che consenta in tempo reale o in tempi rapidi di far pervenire al Parlamento tutte le proposte di atti legislativi che la Commissione adotta. Questo perché? Per perché è possibile da parte dei parlamenti nazionali di partecipare al controllo di sussidiarietà delle norme europee. Oggi il protocollo sul trattato di Lisbona prevede una prerogativa specifica che è definita dal controllo di sussidiarietà, ossia il controllo degli atti legislativi al rispetto dei limiti legati al legiferare su ciò che è necessario fare per raggiungere gli obiettivi con normativa europea e non è possibile farle in maniera efficace con norme nazionali. Quindi la sussidiarietà è la valutazione del corretto intervento europeo in materia di competenza concorrente tra Stati membri e Europa. Ciascun Parlamento nazionale ha la possibilità di adottare un parere motivato e in caso di parlamenti bicamerali ogni camera può adottare un parere motivato, si chiama così la formula, sul rispetto o meno del principio di sussidiarietà e inviarlo alla Commissione Europea. Quindi un c’è un dialogo diretto tra i parlamenti nazionali e la Commissione e ovviamente le istituzioni europee che poi sarà trasferito alle altre istituzioni legislative. C’è un termine fissato di 8 settimane, quindi voi sarete chiamati, secondo me, anche se non avete ovviamente un’ipotesi del genere, a prevedere un’apposita sessione che vi consenta nel termine di 8 settimane di decidere se intervenire o meno e in che modo su un determinato atto legislativo, anche per testimoniare la consapevolezza che si dà un parere favorevole rispetto al principio, non deve essere un parere necessariamente contrario, può essere anche un parere favorevole o può decidere un parlamento o la Camera, il Consiglio Grande e Generale di non intervenire, ma può decidere di intervenire per testimoniare il proprio favore o il proprio dissenso. Ci sono due procedure, si chiama di cartellino giallo e di cartellino arancione che sono legate al numero di parlamenti nazionali, di Camere Nazionali che dovessero decidere di dare un parere motivato contrario, perché qualora i pareri motivati non rappresentino almeno un terzo dell’insieme dei voti attribuiti ai vari parlamenti nazionali, il progetto deve essere riesaminato dalla commissione e può essere mantenuto, modificato o ritirato. Questa la procedura di cartellino giallo. Qualora invece i pareri motivati ai parlamenti nazionali rappresentino la maggioranza semplice dei voti attribuiti tutti i parlamenti, allora, spetta al Parlamento Europeo, al Consiglio decidere di confermare quella proposta di atto con determinate maggioranze qualificate previste, quindi cè la procedura cosiddetta del cartellino arancione. È una procedura precisa, prevista anche a livello europeo, che può essere applicata se c’è un numero rilevante di parlamenti nazionali che indicano un parere contrario rispetto a una proposta legislativa. Ad ogni modo vi è la possibilità di far valere il cosiddetto dialogo politico, cioè di poter indicare o indirizzare alla Commissione una parere su un progetto di atto anche non legislativo. Quindi è previsto dal trattato di Lisbona un dialogo costante continuativo e un confronto che assume carattere anche vincolante sulla sussidiarietà più politico su altri temi tra le istituzioni europee, la Commissione in primis e i parlamenti nazionali a prescindere dai governi, a prescindere dagli esecutivi. È una prerogativa propria dei parlamenti nazionali che i parlamenti stanno iniziando ad utilizzare sempre di più perché c’è voluto tempo, anche in Italia o nei singoli parlamenti, per mettere a regime anche sono state necessità di riforme dei regolamenti parlamentari interni per prevedere delle procedure apposite che consentono di individuare delle sessioni o delle facoltà in cui sarebbe possibile analizzare questi atti normativi europei e far sentire la propria voce. C’è però un altro elemento che, secondo me, rafforza o su cui è necessario ragionare per rafforzare il ruolo del Parlamento una volta prodotto l’ingresso come accordo associazione l’Unione Europea. È il rapporto col governo rispetto agli indirizzi politici che il governo assume a livello europeo. Voi avrete necessità di individuare nel comitato misto delle figure con cui il vostro governo interloquirà sempre più spesso e costantemente con la Commissione, con le istituzioni europee. Vi è un obbligo previsto specificamente prima dei Consigli europei di venire in aula da parte del governo, rappresentare le posizioni che intende assumere nel Consiglio europeo successivo e anche ricevere, diciamo, far votare degli atti di indirizzo dalle Camere che sono delle vere e proprie risoluzioni di maggioranza, e di opposizione ovviamente, o anche unitarie se dovesse esserci la possibilità. Il governo è obbligato a venire in aula prima dei Consigli europei formali per discutere col Parlamento dell’indirizzo che intende seguire al Consiglio seguente. In Italia solitamente la settimana stessa in cui si svolge il Consiglio, c’è una sessione con le comunicazioni della presidente del Consiglio dei Ministri in Parlamento e questo consente di rafforzare il ruolo del Parlamento nella funzione di indirizzo politico rispetto alla posizione che il governo assume nelle istituzioni europee. Lo stesso accade successivamente. Vi è la possibilità che il governo informi le Camere negli sistemi bicicamerali o la Camera o il Parlamento degli esiti del Consiglio stesso. Lo può fare in aula, lo può fare nelle commissioni competenti. Questo è rimesso, semmai alla singola autonomia dei singoli parlamenti nazionali. Oggi l’ordinamento italiano prevede la possibilità di due relazioni annuali che danno l’indirizzo e che fanno un punto sul lavoro svolto l’anno precedente con la relazione consuntiva sul lavoro europeo svolto l’anno precedente una relazione programmatica da adottare prima della fine dell’anno sugli indirizzi politici complessivi da seguire a livello europeo l’anno successivo. Terzo elemento sul quale riflettere è non più la fase ascendente, non più il rapporto parlamento, governo da un punto di vista di indirizzo politico, ma la fase discendente di recepimento, di attuazione delle norme europee nell’ordinamento interno, l’ordinamento sammarinese che avviene, come vi dicevo, in via diretta ed immediata anche da parte dei giudici nazionali, ma è evidente che prevede un ruolo preminente da parte del Parlamento in via ordinaria. Che cosa è previsto in Italia? E potrebbe essere uno strumento di riflessione anche per il vostro ordinamento. L’idea è quella di prevedere uno strumento, da noi si chiama legge di delegazione europea, da approvare in un determinato momento dell’anno. La nostra legge prevede entro il 28 febbraio di ogni anno, poi abbiamo aggiunto la possibilità di una seconda legge di delegazione europea entro il 31 luglio, per fare cosa? Per indicare l’insieme delle direttive principalmente in scadenza nei mesi successivi che l’Italia si impegna, come parlamento, a recepire nel nostro ordinamento entro un termine previsto. Quindi la legge di delegazione europea è lo strumento attraverso il quale lo Stato italiano opera il recepimento delle direttive europee e delle normative anche, per esempio, quelle di regolamenti che richiedono norme di attuazione o di esecuzione tecnica specifica. Quindi voi vi trovate a recepire al momento entrate in vigore l’accordo associazione un centinaio di norme europee che sono quelle in vigore in quel momento. Ma ovviamente le norme europee sono in continua evoluzione, così come le norme di qualunque ordinamento. E voi avete la necessità di adeguare l’ordinamento in modo dinamico all’evoluzione legislativa successiva a quel momento dell’Unione Europea, ovviamente nelle materie di competenza dell’accordo di associazioni. Come si fa questo?
Avete la possibilità di volta in volta appena viene approvata una direttiva, di arrivare in aula o nei tempi previsti per recepire quella singola direttiva, oppure di prevedere uno strumento omnibus che a scadenza prefissata una o due volte all’anno, possa tener dentro l’insieme delle direttive in scadenza da lì ai mesi successivi per adeguare il vostro ordinamento in modo esaustivo, evitando il rischio di risarcimento danni se il privato, come vi ho detto prima, non si vede poi riconosciuto un diritto direttamente allo Stato. Oppure il rischio che il giudice la disapplichi e armonizzare il vostro ordinamento in modo strutturale e in modo ordinato alla evoluzione normativa dell’Unione Europea. Questo è un ovviamente uno strumento innovativo, tra virgolette, su cui dovreste ragionare in Consiglio Grande e Generale. Non entro nei tecnicismi del funzionamento perché poi ogni ogni parlamento ha una propria modalità di funzionamento all’interno delle singole commissioni anche parlamentari. Però da questo punto di vista io credo utile immaginare una commissione con competenze europee, o all’interno delle vostre commissioni stesse o una nuova commissione parlamentare che abbia semmai competenza politiche europee. Noi abbiamo la 14ª commissione alla Camera cui io sono membro che è proprio commissione politica dell’Unione Europea. Al Senato c’è stato un accorpamento a seguito della riduzione del numero dei parlamentari e c’è una commissione che racchiude esteri difesa e politica europea. Però immaginare di attribuire una competenza specifica ad una commissione già esistente o nuova credo che sia utile perché poi il lavoro preliminare prima di arrivare in aula si fa, come immagino anche da voi, sempre anche nelle commissioni competenti.
C’è un’altra tipologia di strumento che noi abbiamo in Italia che si chiama Legge europea, non legge di delegazione europea, legge europea. Che cos’è la Legge europea? È una legge che è volta ad adeguare il nostro ordinamento a quello europeo, soprattutto in relazione ai casi di preinfrazione o avvio di contestazioni europee. Voi sapete che esistono procedure di infrazione a livello europeo che avvia la Commissione, cioè procedure di dialogo e di contestazione sulla coerenza o compatibilità della norma interna con la norma europea. Abbiamo avuto una procedura in itinere legata, per esempio, al nostro rispetto alla normativa interna italiana sulla direttiva Bolkenstein, per esempio, sapete bene. E ci sono spesso delle procedure vari paesi, ne abbiamo decine anche in Italia, ma in tutti i paesi, procedure di infrazione che sono in una fase precedente addirittura la richiesta di ricorso per inadempimento alla Corte di Giustizia. Però quando un ordinamento nazionale vuole adeguarsi e provare a far chiudere una procedura di infrazione aperta, potreste avere l’esigenza di adottare uno o più norme nuove per adeguare al confronto in atto con l’Europa alcune normative interne. Quella è potreste individuare uno strumento ad hoc che noi chiamiamo legge europea o legge di adeguamento all’ordinamento europeo. Questo per quanto riguarda il ruolo del Parlamento e le ipotesi di interventi istituzionali che riguardano, per ricapitolare il sistema giudiziario, il rapporto tra governo e parlamento, esecutivo e legislativo e il ruolo che il Parlamento ha nel dialogo diretto con le istituzioni europee, oltre che il ruolo di protagonismo che ha necessità di avere nell’adeguamento dell’ordinamento interno alle norme europee o di recepimento costante alle nuove alle nuove norme che verranno adottate da qui ai prossimi anni dall’ordinamento europeo.
Il vostro ordinamento diventerà un ordinamento multilivello, così come già lo è rispetto a tante altre norme internazionali o convenzioni internazionali che ovviamente vi trovate ad applicare, su cui lavorate. Uno: ragionate se è indispensabile e necessario un adeguamento dei principi fondamentali legislativi, perché l’appiglio normativo costituzionale in Italia rispetto alla partecipazione dell’Italia norme europea è dettato all’articolo 11 della Costituzione che fa riferimento a organizzazioni internazionali che perseguono fini di pace a livello internazionale. Valutate se è utile o necessario anche un adeguamento vostro di rango costituzionale rispetto al rapporto futuro tra l’ordinamento di San Marino e l’ordinamento europeo o se la vostra giurisprudenza costituzionale o i principi costituzionali del vostro paese consentono di far interagire i due ordinamenti già con lo Stato della situazione legis attuale. L’altro elemento di cui stavo parlando è l’elemento legato alla formazione. Io credo molto utile lavorare a partire dalle università, semmai per aprire a corsi di formazione, a corsi di lauree sul diritto europeo o a corsi che tengano conto il diritto europeo, perché la formazione degli studenti, così come la formazione della pubblica amministrazione, così come la formazione poi di tutte le istituzioni del paese sulle norme, sui temi di carattere europeo, diventa un tema decisivo per cogliere soprattutto le opportunità, che secondo me sono enormi, legate all’ingresso in un mercato unico europeo, in un sistema di valori che poi è quello rappresentato dall’Unione Europea. Sono opportunità uniche legate alla formazione, agli scambi culturali, al rafforzamento professionale dei lavoratori, al rafforzamento della pubblica amministrazione, progetti che potranno ottenere sostegno con finanziamenti europei legati al rafforzamento stesso delle università, della pubblica amministrazione, il sistema giudizio opportunità nuove per le aziende che si troveranno un mercato più ampio su cui lavorare. Perché tutte queste opportunità possano essere colte, è evidente sia necessario una riflessione rispetto a come adeguare l’ordinamento giudiziario, legislativo e ovviamente la parte esecutiva a questo nuovo sistema di opportunità, di diritti, di regole, di valori con cui vi troverete a confrontarmi nel momento in cui entrerà pienamente in vigore l’accordo di associazione.
Nicola Renzi (Rf) – Presidente: Intanto io mi sento di ringraziarla davvero perché è stato un momento prezioso che ci fa riflettere non solo sull’organizzazione interna, ma sulla nostra organizzazione in proiezione su quello che finalmente speriamo possa arrivare in tempi rapidi, cioè l’accordo di associazione. Non le nascondiamo che questi sono alcuni dei punti cruciali sui quali ci stiamo proprio interrogando per cogliere questa opportunità.
Mirko Dolcini (D-ML): Ringrazio anch’io l’onorevole De Luca per la sua esposizione molto chiara, tecnica, evidentemente competente. Si è accennato alle procedure di infrazione. Anche sull’accordo è previsto un iter nel caso in cui le normative non siano applicate. Nel nostro accordo si fa riferimento a tutto un meccanismo per cui sono coinvolti il Comitato misto, la Corte di Giustizia, nonché l’arbitrato internazionale. Le volevo chiedere in base a quello che può aver visto se la procedura di infrazione prevista per San Marino è la stessa sostanzialmente di quella prevista per gli Stati membri e in caso di infrazioni, in base alla sua esperienza in questi anni maturata, quanto possono incidere le infrazioni nel bilancio dei singoli Stati.
Paolo Crescentini (Psd): Innanzitutto desidero esprimere un ringraziamento veramente sentito all’onorevole De Luca per la fantastica audizione, perché veramente ci ha aperto un mondo che conoscevamo in parte e quindi ci ha permesso di arricchire il nostro bagaglio. Questo è veramente importante, soprattutto alla luce di quello che sarà il futuro per il nostro paese una volta firmato l’accordo di associazione. Vado subito alla domanda/considerazione: con l’accordo di associazione ci si apre un mondo nuovo anche per quanto riguarda l’economia, possiamo diventare sicuramente attrattivi anche per quegli imprenditori esteri internazionali che intendono operare nel mercato europeo, e penso che San Marino sotto questo aspetto possa diventare anche attrattivo, e su questo magari sarà lei a darci indicazioni in più. Le volevo anche chiedere questo: siccome una volta che verrà firmato l’accordo di associazione si aprirà un mondo nuovo per la Repubblica di San Marino, per i sammarinesi, ma anche per noi parlamentari o consiglieri, questo significa dover non recepire le varie disposizioni, le varie direttive dell’Unione Europea e quant’altro, il che implica anche un cambio di approccio per quanto riguarda il ruolo di consigliere della Repubblica di San Marino, perché mi sembra di capire che qui i lavori potrebbero aumentare a dismisura, anche con delle calendarizzazioni, forse settimanali, del Consiglio Grande Generale. A fronte di ciò, qual è l’invito o meglio, qual è la sua opinione che può dare in merito a quello che dovrà essere l’approccio anche da un punto di vista della preparazione di noi consiglieri, ma anche delle future generazioni che nella prossima legislatura si approcceranno ad entrare in Consiglio Grande Generale? Perché tra 3 o 4 anni ci sarà la scadenza elettorale, pertanto dovremo sicuramente essere ancor più preparati e sapere anche quello che andremo incontro.
Luca Lazzari (Psd): Ringrazio anch’io l’onorevole De Lucca per la relazione che ci ha fornito degli elementi nuovi che fin qui non avevamo raccolto e che ci sono senz’altro molto molto utili nel nostro percorso di associazione con l’Unione Europea. Probabilmente il mandato più importante che noi abbiamo ricevuto come commissione è quella per l’appunto di rafforzare il ruolo, la centralità del Consiglio Grande Generale. Le faccio un esempio: l’anno passato noi come Consiglio abbiamo prodotto, mi pare, una dozzina di provvedimenti di legge, ma la maggior parte di questi sono stati comunque redatti e avviati l’iter dalle Segreterie di Stato competenti. Questo è in forte contrasto con i 170 decreti delegati che, è vero, qui da noi hanno l’obbligo di una ratifica del Consiglio Grande Generale, ma è anche vero che non partono da questo schema che lei prima ci ha descritto così definito. Però quello che io ho capito dalla sua relazione è che comunque tutto il processo di recepimento normativo dell’Unione Europea porterà, in ragione quasi di un automatismo, a una maggiore centralità del Consiglio Grande Generale. Le domande che pongo sono due. Uno è se lo schema di regole dell’Unione Europea definisce o interviene anche su quelli che sono i rapporti fra i poteri dello Stato, magari secondo elementi di garanzia. L’altra domanda riguarda il processo di recepimento, il quale se da una parte ci dà centralità, dall’altra, come diceva il consigliere Crescentini, porterà un aggravio e un carico di lavoro per il Consiglio Grande Generale e anche all’arricchimento di competenze e di conoscenze. Noi qui abbiamo già un problema in quanto da noi la politica è intesa diciamo come servizio, non c’è una professionalizzazione dell’attività consiliare. Già adesso questo schiaccia ognuno di noi tra quello che è il proprio lavoro, quelli che sono gli impegni familiari e per l’appunto l’attività consigliare, che negli anni è diventata sempre più intensa, ricca e totalizzante, insomma. Quindi, non so se questa è una scelta tutta nostra che riguarda la professionalizzazione o meno del ruolo, però magari anche sul piano organizzativo. Le chiedo se può portarci degli esempi di modelli di altri parlamenti per almeno trovare una via, una soluzione rispetto a quelle che appunto sono le regole che definiscono l’attività parlamentare.
Gian Carlo Venturini (Pdcs): Anche io mi associo ai ringraziamenti al professor De Luca perché ci ha fornito degli elementi, a mio avviso, che noi solitamente tendiamo a valutare quella che è la nostra attività. Invece ha espresso dei suggerimenti e ha evidenziato alcune tematiche che riguardano poi il recepimento notevole del diritto comunitario e le modalità che dovremmo sicuramente affrontare. Poiché il suo intervento di oggi è stato registrato, sarà l’occasione di andarlo ad ascoltare nei vari momenti di attuazione di quello che sarà il dibattito anche interno. Una riflessione riguarda il fatto che anche noi abbiamo il decreto delegato, che forse è simile a quello del decreto legislativo vostro, e c’è una procedura sì rapida nell’emissione, ma poi comunque viene ratificato in Consiglio. Anche se nel nostro piccolo abbiamo un certo numero di decreti delegati che vengono emessi, dovremmo forse trovare una formulazione che possa semplificare da una parte la ratifica e accorciare i tempi, ma dall’altra garantire al Parlamento il suo controllo, come quello che diceva lo schema che va in commissione con un parere preliminare. Queste sono sicuramente riflessioni che potremmo fare e valutare. L’altro aspetto invece è quello che, dovendo recepire questo diritto comunitario dopo l’accordo di associazione, di cui auspichiamo che avvenga la firma e la ratifica quanto prima, si pone il problema della modalità di recepimento. Il professore ha detto che alcune cose le possiamo recepire attuando dei regolamenti europei, mentre altre richiedono delle norme specifiche che possono semplificare. Dico questo perché altrimenti al di là poi della scelta che si dovrà fare, sorgono le riflessioni sulla funzione del consigliere o qui sta tutto il giorno a ratificare continuamente. Mi chiedo se, visto che ci sono alcuni casi dove è necessario e indispensabile la legge, per gli altri che possiamo recepire semplicemente adottando dei regolamenti già vigenti dell’ordinamento europeo o altre procedure per semplificare, magari nella sua esperienza ci sia una norma che possa indicare, ad esempio, quelli estremamente tecnici dove ci sono degli aspetti che sono prettamente specifici dei requisiti tali che non è che si possono modificare in San Marino o altri, magari prevedendo, non dico l’automatismo, ma una procedura più semplificata. Spero riesca a darci qualche suggerimento, vista la sua esperienza, poiché questo potrebbe essere utile quando ci dovrò mettere mano al recepimento di queste procedure e direttive comunitarie.
Iro Belluzzi (Libera): Mi accodo logicamente ai ringraziamenti, professore per la relazione che ci ha proposto, e chiedo una cosa in più, ovvero se può lasciare agli atti della commissione i documenti che ho visto e ha consultato perché credo che siano più ancora più approfonditi rispetto al già corposo intervento che ha fatto e sono estremamente utili. È consapevolezza di chi segue la politica, il percorso verso l’associazione con l’Unione Europea, del grande lavoro che dovrà svolgere la Repubblica di San Marino per poter adeguarsi a quelle che sono le norme e per essere in grado di confrontarsi e essere proattivi con l’Unione Europea. Un elemento importante, io credo, che debba far riflettere il Parlamento, è anche la capacità della Repubblica di San Marino di intessere un rapporto sempre più proficuo e profondo però con la vicina Italia, proprio per avere un elemento di garanzia, anche perché, in funzione della nostra dimensione, delle forze in campo e delle risorse che abbiamo, non abbiamo la capacità di svolgere probabilmente quella proattività o influire, o influenzare quelli che possono essere elementi che vengono adottati all’interno dell’ordinamento europeo, i quali potrebbero essere estremamente pesanti per la nostra realtà. Un elemento essenziale è quello del recepimento, perché è vero che nel momento in cui siamo parte dell’Europa o comunque abbiamo firmato l’accordo, dovremmo comunque adottare o comunque siamo sottoposti a tutte le indicazioni e tutte le prescrizioni dell’ordinamento. È importantissima la modalità, l’importanza e la conoscenza delle norme come elemento non soltanto di opportunità per il tessuto economico ma di democrazia. La conoscenza delle norme che regolano il contesto in cui ci si inserisce, per cui ogni cittadino dovrà essere pienamente consapevole. Questo qui è un tema su cui più colleghi hanno centrato la preoccupazione su come poterla raggiungere velocemente.
Piero De Luca – relatore: Ringrazio innanzitutto voi per la disponibilità all’ascolto, sperando di aver dato qualche spunto di riflessione interessante e utile per i vostri lavori anche in riferimento alla mission proprio istitutiva di questa commissione. Sebbene su alcune cose ci vorrà tempo per riuscire ad adeguare il sistema interno a quello europeo, bisogna partire subito, innanzitutto rispetto al recepimento degli atti che sono indicati negli allegati. L’invito che farei è a istituire subito un presidio, una commissione, un punto, decidete voi in che modo, che avvii immediatamente i lavori legati allo screening delle normative già inserite negli allegati dell’accordo di associazione. Le norme da verificare sono già tante per individuare i punti su cui è indispensabile adeguare, mettere a sistema e uniformare il vostro ordinamento. Le direttive andranno necessariamente con una norma di diritto interno autonoma, mentre i regolamenti, pur avendo un impatto e un’efficacia diretta, potrebbero richiedere di adeguare degli aspetti tecnici di alcune normative interne. Si tratta di un lavoro molto corposo e strutturato, da farsi ovviamente anche col supporto degli uffici legislativi del Consiglio, così come del Governo. Credo sia indispensabile un rapporto di forte collaborazione istituzionale tra strutture tecniche del Governo e del Parlamento in questa fase per individuare i percorsi da mettere in campo, perché ci vorranno probabilmente mesi o anni prima di adeguare, anche se un periodo transitorio è previsto. È un lavoro da iniziare a fare per farsi trovare pronti allo scadere del termine transitorio previsto allo stesso accordo, perché gli anni indicati sembrano tanti, ma in realtà così non è. Inoltre, a questa “fotografia statica” si aggiungerà tutta la nuova normativa che sarà approvata nel corso del tempo, per cui c’è un’esigenza di adeguare alle norme oggi indicate negli allegati e a quelle future. Mi collego anche alla riflessione sul ruolo del Parlamento, che dovrà assumere una professionalizzazione sempre più forte e strutturata, quantomeno rispetto a queste tematiche di carattere europeo, perché è un lavoro che sarà costante. L’ordinamento europeo è un ordinamento vivo, in continua evoluzione, in continua espansione, in continuo rafforzamento, per cui è evidente che il ruolo del Parlamento, se vuole essere non solo protagonista nella fase discendente di attuazione della norma europea, ma anche proattivo nella fase ascendente, cioè di dialogo politico con le istituzioni europee, ha necessità di trovare degli strumenti e delle modalità di funzionamento nuove e innovative. In Italia, la norma principale di recepimento è la legge di delegazione, attraverso la quale il Parlamento elabora un testo e dà i principi e criteri direttivi legati al ricevimento delle direttive, e il governo poi adotta i decreti legislativi. In caso di infrazione, il comitato misto previsto è uno strumento differente dall’iter tradizionale delle procedure di infrazione e consente un dialogo più politico. Ritengo che questa sia una forma più soft e anche giusta rispetto al tipo di strumento, perché consente un dialogo tra la Commissione e la Repubblica di San Marino per dirimere eventuali controversie. A me pare una norma oggettivamente ragionevole e di buon senso, affidata alla sensibilità politica che tenga conto anche della specificità della Repubblica di San Marino. Il tener conto delle specificità durante l’ordinamento sarà un elemento decisivo del dialogo politico. Sull’economia, chiudo su questo, secondo me ci saranno delle opportunità enormi e nuove per aziende, per imprese, anche di attrazione di nuovi investimenti qui a San Marino, perché sarà un territorio unito a un mercato più ampio di 500 milioni di persone che consentirà di avere un sistema di regole comuni a tutto il mercato europeo. Sarà utile lavorare, per esempio, su uno “sportello Europa,” cioè creare uno strumento che consenta anche alle aziende di poter avere conoscenza delle opportunità di finanziamenti, di progetti, di fondi europei che l’accordo di associazione apre. Sarà utile anche elaborare e creare un vero e proprio portale web europeo con una raccolta, un inserimento e un aggiornamento costante della normativa europea, che possa essere messa a disposizione della politica, dei membri del Consiglio Grande Generale, del Governo, ma anche dei cittadini o degli operatori del diritto. Il lavoro da fare è duplice e tanto, ma il messaggio che vorrei lasciarvi è che è davvero una grande opportunità che si apre, che va colta, e lo state affrontando con l’approccio corretto e nei tempi giusti. Questo processo sarà un’opportunità per rafforzare il ruolo del Parlamento e per creare nuove opportunità economiche, sociali, nuovi diritti, nuovi elementi di tutela che potranno rappresentare un elemento di crescita e sviluppo futuro per il vostro paese.
Comma 1 – Comunicazioni
Nicola Renzi (Rf) – Presidente: Se non avete problemi, intanto vi darò alcune comunicazioni prima di tornare sull’audizione per qualche riflessione che potrebbe essere utile. La prima comunicazione è che la Commissione di Venezia ha risposto positivamente alla nostra richiesta di audizione e collaborazione, fissando la data del 2 dicembre e indicando anche i soggetti delegati che vi parteciperanno. Inoltre, il 12 novembre prossimo si terrà un incontro informale da remoto fra i presidenti e i delegati della Commissione di Venezia, insieme al commissario della legge Fabio Giovagnoli, che è il nostro referente per l’ordine giudiziario. L’iter che vorremmo seguire in preparazione del 12 novembre è che io e il presidente incontreremo prima il commissario Giovagnoli per preparare questo incontro informale, decidendo poi se farlo da remoto o in presenza. Questo momento è molto importante perché vorremmo ricevere da voi membri della commissione, soprattutto da coloro che hanno sollecitato l’audizione, le istruzioni e le indicazioni sugli argomenti specifici sui quali desideriamo che la Commissione di Venezia ci riferisca e collabori. Vi preghiamo, quindi, di darci indicazioni sul perimetro degli interventi, o oggi aprendo il dibattito o in seguito, prima del nostro incontro con il commissario Giovagnoli. Un’altra comunicazione è che il 19 settembre la professoressa Maria Alessandra Sandulli ha declinato a mezzo mail l’invito ad essere audita da questa commissione. Valuteremo se rispondere con una lettera di ringraziamento, come abbiamo già fatto con Emiliani e Barbera; se non ci sono contrarietà, invieremo la lettera classica di ringraziamento. Come presidenti, abbiamo anche inviato una lettera per l’iscrizione di un apposito comma nella seduta consiliare di ottobre per il riferimento previsto dalla legge istitutiva della commissione, e su questo possiamo confrontarci sulle modalità da utilizzare. Pensavamo di fare un riferimento molto asciutto, dato che dobbiamo semplicemente rendere conto della documentazione prodotta. Credo che i documenti debbano essere pubblici, proprio nell’area pubblica del Consiglio Grande Generale, e che anche i contenuti delle audizioni svolte siano pubblici e consultabili su Synedrio. Si sta lavorando per sbobinarli in modo che ci sia anche il supporto di semplice lettura e non solo audio/video. Dobbiamo anche rendere conto delle sedute e delle audizioni in programma fino a fine anno, immaginando che i lavori di confronto veri e propri inizieranno verosimilmente dall’anno nuovo.
Emanuele Santi (Rete): Per quanto riguarda il riferimento in Consiglio Grande Generale ad ottobre, credo che il rispetto dei tempi sia dovuto, poi saranno le Loro Eccellenze a decidere se inserirlo. Vorrei capire, però, anche con la commissione, se il calendario delle audizioni che abbiamo già fissato è tutto confermato, poiché gli impegni in Consiglio e commissioni saranno tanti. Per me, il calendario approvato è un calendario a cui ci si deve attenere, anche perché abbiamo preso impegni ben precisi con le persone che verranno audite. Vorrei chiedere conferma per poter organizzare la nostra vita: sono confermati gli appuntamenti, come la doppia o tripla audizione in due sedute per martedì 21, così come per il 28, il 4, e andando avanti. Vorrei anche capire se il calendario è confermato alla luce dei nuovi appuntamenti, come il 2 dicembre per la Commissione di Venezia; mi chiedo anche se martedì 11 ci sarebbe un vuoto da poter riempire magari ascoltando l’avvocato Crescentini, che non era potuto essere ascoltato martedì 7.
Nicola Renzi (Rf) – Presidente: Grazie Santi, perché questo è la prima cosa da chiarire per tutti i commissari. Nonostante il momento politico sia intenso, credo che sarebbe opportuno cercare di mantenere le date il più possibile, soprattutto perché stiamo lavorando all’individuazione di queste date da tanto tempo e ci sono anche trasferte da considerare. Chiederei ai funzionari di riepilogare le date. Mi dicono i funzionari che le Loro Eccellenze sono già coordinate e pienamente a conoscenza. Lasciamo fare il riepilogo in modo da segnarci tutti le date, che daremmo per ora per definitive.
Funzionario: Martedì 21 ottobre avremo la mattina il professor Guidi e il professor Giostra, e il pomeriggio il professor De Vergottini. Il 28 ottobre avremo la mattina la dottoressa Pierfelici e il dottor Fabio Giovagnoli, mentre a pomeriggio il dottor Gilberto Felici. Il 4 novembre vedremo in prima mattinata il dottor Giovanni Canzio e il pomeriggio alle 15 l’avvocato Valeria Ciavatta. Queste sono le date che abbiamo.
Comma 2 – Audizioni
Nicola Renzi (Rf) – Presidente: Torniamo sull’audizione del prof De Luca. Ringrazio chi ha proposto questa audizione perché a mio avviso è stata veramente molto utile e molto interessante, in quanto siamo riusciti a dire pubblicamente alcune cose che potevano essere patrimonio comune. Io temo purtroppo che stiamo accumulando un importante ritardo rispetto all’adeguamento necessario per il grande passo e per mettere in moto la macchina. Parlo come Nicola Renzi, non nella veste di presidente, ma di semplice membro, e sono convinto che non possiamo permetterci di tergiversare ulteriormente. Tutta la fase negoziale, che dura da oltre 10 anni, ha visto l’applicazione del cosiddetto metodo del semaforo, per cui su ogni atto abbiamo prodotto un’analisi che indicava: luce verde, recepibile senza problemi,, luce rossa, individuando le linee rosse per cui dovevamo chiedere periodi di adattamento, sapendo che non è possibile chiedere esenzioni a priori, e luce arancione, applicabile con delle modifiche, esercitando quel minimo di discrezionalità possibile, come il sistema di quote sulla libera circolazione delle persone, viste le nostre dimensioni. Un lavoro enorme è già stato fatto, ma è risalente nel tempo e necessita di una revisione complessiva. Mi piacerebbe sapere se questo lavoro di rielaborazione è stato mantenuto nei sei anni successivi e se oggi il Parlamento è in grado di fornire un semaforo attuale. Non ho più sentito parlare del recepimento dinamico e automatico dell’acquis. Dobbiamo condividere le informazioni, altrimenti, arrivata la firma, inizieremo a discutere come applicare le cose. Chiedo se il gruppo che dovrebbe seguire il semaforo o gli adattamenti è operativo. Dobbiamo metterci a sistema, altrimenti l’amministrazione sarà soverchiata, e rischiamo di arrivare alla firma e di non riuscire a mettere in moto la macchina. Dico questo da sammarinese convinto dell’accordo, e credo che dobbiamo far lavorare al meglio ciò che abbiamo con la nostra organizzazione interna. Il riferimento dell’onorevole De Luca, pur sembrando terrorizzante per chi non è nel merito, sta proprio il motivo principale per fare l’accordo: avere quel posto a tavola, quella sede, come il Comitato Misto, per avere informazioni in anticipo, avere voce in capitolo e non dover sempre rincorrere atti che ci vengono comunque imposti. Non possiamo disconoscere l’acquis, con cui le nostre aziende e cittadini hanno a che fare quotidianamente, a meno di non ritagliare San Marino e rincollarlo in un altro continente. Noi siamo abituati a confrontarci da decenni con la legislazione superiore, come la CEDU, e i nostri operatori del diritto sono già abituati a ragionare con questo schema mentale. La nuova parentesi sarà impegnativa ma ci dà l’opportunità di avere voce in capitolo in fase redigente. L’accordo di associazione è l’estrinsecazione massima della nostra sovranità, perché veniamo finalmente riconosciuti dagli altri. La grande domanda è: saremo all’altezza? Riusciremo ad essere tempestivi? Spero di sì, ma serve uno scatto e un’operatività molto importante, ad esempio ragionando sulla legge sulle residenze per l’applicazione della clausola di salvaguardia.
Iro Belluzzi (Libera): Accettiamo il suo europeismo, Presidente, ma questa commissione ha altre funzioni. Vorrei partire dalla relazione del professor De Luca, che ha fatto un refreshing sugli impegni e sulla realtà. Non credo che nessuno avesse dimenticato gli obblighi e gli oneri del percorso, ma forse qualcuno lo aveva dimenticato nel refrain dell’europeismo ideologico. È giusto che ci venga ricordato quanto sarà impegnativo non essere travolti da una dimensione enormemente più grande, 500 milioni di cittadini rispetto ai 34.000 residenti. Dovremmo rispolverare l’approccio di Pasquale Valentini, che cercava una cooperazione strutturata con la vicina Italia, che io vedo estremamente collegata e d’ausilio per la Repubblica. Quello che deve svolgere questa commissione è trovare le modalità e presentare le modifiche per il recepimento delle norme, nella funzionalità del Consiglio Grande Generale. Un elemento essenziale che sembra essere elemento ostativo per la piena attuazione è il memorandum o clarify addendum in materia finanziaria con l’Italia. Ho paura che qualcuno creda sempre di meno nel fatto che questo percorso debba essere raggiunto, e troppe sono le istanze per far sì che questo percorso naufraghi. Dobbiamo trovare i modi per far sì che la conoscenza e le norme da recepire diventino velocemente parte del nostro ordinamento, magari con un portale. Molte norme che il Parlamento sta approvando sono già in linea con le direttive europee, il che è un passaggio importante. Devo concludere perché è incongruente ciò che diciamo qui sulla decretazione con quello che purtroppo troviamo scritto nei pdl ancora da approvare; occorre avere una visione coerente e che il governo sia consapevole di quello che questa commissione sta decidendo.
Mirko Dolcini (D-ML): A differenza del collega Belluzzi, l’intervento del presidente Renzi è stato puntuale. Anch’io ringrazio De Luca per l’illustrazione chiara dell’impatto dell’accordo sulle nostre istituzioni. Condivido che siamo in ritardo nella valutazione di questi impatti. L’onorevole De Luca ha parlato di mettere in atto fin da subito un presidio per valutare i tanti allegati e adeguarci subito. Abbiamo sentito che ci sono procedure di infrazione, e anche se l’accordo ha un aspetto più calmierato per San Marino, ci sono conseguenze anche economiche se la normativa non viene applicata. L’intervento di Renzi è puntuale perché ci fa quasi pensare che i lavori di questa commissione sulle riforme andrebbero posticipati a quando avremo capito veramente quali dinamiche istituzionali vanno modificate a seguito dell’accordo. Se il Consiglio Grande Generale torna al centro, dobbiamo capire come lo farà nell’aspetto dell’Unione Europea. Non possiamo sottostimare l’impatto, che è evidente, soprattutto perché questo accordo è inedito per la sua vastità con 25 allegati su 35. Non mi preoccupa l’ordinario, che richiederà anni per arrivare a un livello standard di automatismi, ma mi preoccupa l’impatto iniziale, il rodaggio. Fare le cose per tempo è fondamentale, aspettare fino all’ultimo per studiare un fascicolo enorme porterà a un processo disastroso. Non possiamo far finta di voler modificare il nostro impianto istituzionale senza sapere cosa comporterà l’accordo di associazione.
Paolo Crescentini (Psd): L’audizione è stata molto importante, e va apprezzata l’esperienza di autorevoli personaggi da oltre confine. Ricollegandomi a Dolcini sul presidio, è vero che siamo in ritardo, ma come Consiglio Grande Generale abbiamo dato mandato attraverso un ordine del giorno al Segretario di Stato per gli Affari Interni di predisporre una relazione che sarà discussa nella prossima sessione consiliare. In quella relazione sarà delineata la mappa di quella che dovrà essere la macchina amministrativa e il cambiamento della pubblica amministrazione in materia di modifiche normative. La relazione affronterà il recepimento normativo, la formazione e le agenzie di controllo. Con questo ordine del giorno, che è lungimirante alla luce della firma imminente, abbiamo cercato di recuperare quello che è stato il tempo perduto, colmando questo gap. La relazione aprirà le porte al futuro della macchina amministrativa del nostro paese. Abbiamo cercato di affrontare la questione con serietà e impegno, e l’audizione con l’onorevole De Luca ha arricchito il lavoro della commissione.
Comma 3 Valutazione degli argomenti da sottoporre alla Commissione di Venezia
Guerrino Zanotti (Libera): Per quanto ci riguarda, non ci sono da parte nostra indicazioni o richieste di porre dei paletti o di chiarire già oggi quali siano i termini del rapporto con la Commissione di Venezia. Ci rimettiamo a quello che sarà l’incontro che avrete a novembre voi come presidenti, sul quale poi ci relazionerete ovviamente.
Enrico Carattoni (Rf): Credo che sia opportuno dare un mandato abbastanza ampio ai presidenti che si dovranno confrontare con gli interlocutori della Commissione di Venezia al fine di chiarire. Io credo che il focus sia sufficientemente chiaro e come commissione mi limiterei a ribadire quello che è il mandato che ci siamo dati, sia con la legge istitutiva che anche poi con il successivo regolamento. Il mandato è quello di indagare, in particolare sotto l’aspetto giurisdizionale, quelle che sono le peculiarità che caratterizzano gli altri piccoli Stati e come questi declinano in particolare le garanzie giurisdizionali delle varie corti costituzionali e degli organi di massima giurisdizione. Dobbiamo vedere quali possono essere i rapporti e valutare se c’è un’ipotesi di accesso diretto a questi organismi giurisdizionali più elevati o meno, e valutare se ci possono essere delle modalità di ricorso per saltum, evitando di potere intasare i tribunali ordinari e ricorrere direttamente ai tribunali superiori. Questo è un po’ il senso, e avendo anche beninteso che c’è una questione non solo politica ma anche diplomatica, ci rimettiamo al prudente apprezzamento che i presidenti sapranno senz’altro tenere in questo colloquio preliminare, ovviamente senza voler scavalcare e interferire.
Manuel Ciavatta (Pdcs): Anche per noi sostanzialmente vale il riferimento fatto dai colleghi che hanno preceduto. Evidentemente in questo confronto immaginiamo che gli argomenti siano quelli di cui la commissione ha mandato per operare. Per cui, rispetto a quelle tematiche che abbiamo condiviso e su cui ci siamo già confrontati, avete chiaramente carta bianca sull’affrontare i temi. Immagino che non sarà un’occasione per capire che cosa ha o che cosa manca a San Marino rispetto a quelle che sono le indicazioni della Corte, perché questo comunque penso avvenga anche normalmente, però è evidente che se ci sono degli spunti o dei suggerimenti, anche proprio in riferimento al nostro essere piccolo stato, penso che questo sia di valore. Anzi, ringrazio anticipatamente per il lavoro che farete.
Nicola Renzi (Rf) – Presidente: Allora intanto ci confronteremo con il commissario Giovagnoli con quello che era emerso dal famoso congresso che ha poi fatto scaturire la necessità in vari commissari di audire la Commissione di Venezia e vi riferiremo quanto prima in modo di essere pronti al meglio anche delle interlocuzioni che avremo il 12 di novembre e se c’è qualche cosa che dovremmo fare nel frattempo ve lo comunicheremo per essere pronti al meglio all’audizione poi del 2 dicembre sulla quale possiamo già fin d’ora dare l’ok. A questo punto ci rimarrebbe l’ultima questione se avete delle sensibilità particolari relative al riferimento al Consiglio Grande Generale della Commissione. Se avete dei suggerimenti su come impostare questo riferimento, su che cosa volete che sottolineiamo. Noi davamo per scontato che a riferire fossero i due presidenti. Se avete invece idee diverse, nessun problema.
Iro Belluzzi (Libera): Per noi va benissimo il riferimento da parte dei presidenti che peraltro sono un consigliere di maggioranza e uno di opposizione. Siete la voce più giusta per riferire all’interno del Consiglio Grande Generale del percorso che stiamo facendo all’interno di questa commissione, per cui c’è massima fiducia da parte di Libera.
Luca Lazzari (Psd): Anche noi riteniamo sia opportuno e corretto che siano i presidenti a presentare una relazione sullo stato dei lavori al Consiglio Grande Generale.